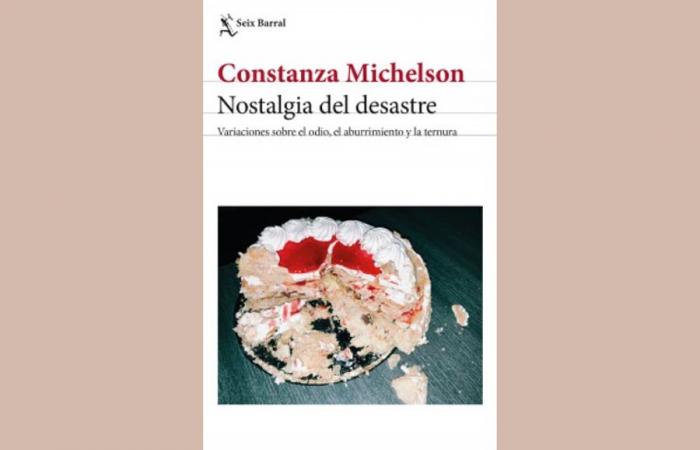Commento al saggio Nostalgia del disastro. Variazioni sull’odio, sulla noia e sulla tenerezzadi Constanza Michelson (Seix Barral, 2024).*
I. RITI SENZA MITI
ENell’ultima riga della prima pagina del libro di Constanza Michelson, leggiamo: «Le cose continuano ad andare; sì, dimenticandone il significato. È un’affermazione sullo stato attuale del mondo che dà completamente il tono del libro, così come un’osservazione nostalgica, poiché può essere fatta solo da qualcuno che conosceva quel significato che ora è perduto. Se, tra l’altro, la nostalgia implica un problema, un disagio presente per ciò che manca, è solo per chi di noi riesce ad avere un rapporto con quel passato e, quindi, è qualcosa che sicuramente scomparirà con noi. Coloro che non sapevano cosa fosse successo prima, né hanno avuto alcun contatto con esso, non possono perdersi nulla; ma non riconosce nemmeno la natura surrogata di ciò che è presente.
Quali sono quelle cose che continuano a marciare, ma hanno dimenticato il loro significato? Beh, quasi tutto: politica, sesso, educazione, storia, per ora. Sono riti spogliati del loro mito. Ma a questo punto, prima di avviarsi verso una deriva “retrotopica” della nostalgia (Bauman), è opportuno inserire una domanda: la percezione di quelle cose che continuano a marciare, ma senza il loro significato, non sarà la prima impressione che ciò che viene fatto su di noi? nuovo, o, meglio, inedito?
E, paradossalmente, noi “malgrado tutto, moderni” abbiamo avuto difficoltà a cogliere la novità; perché sebbene essere moderni significhi essere ricettivi – e anche produttivi – del nuovo, lo abbiamo preferibilmente collocato in una dimensione che chiamiamo futuro, e poi abbiamo fatto di tutto per renderlo prevedibile. Di questo parlava, ad esempio, l’età d’oro delle Filosofie della Storia: il futuro come realizzazione del progresso morale dell’umanità, di un diritto cosmopolita, di forme più perfette di Stato e di libertà, o di grandezze di ricchezza che avrebbero riempire, infine, a tutti (per indicare tre paradigmi moderni: rispettivamente Kant, Hegel e Hume). Ma sembra che oggi sia diverso, e non siamo più di fronte a quel tipo di novità, ma a qualcosa che sarebbe meglio definire “l’inedito”, che è in gran parte avulso dal futuro: ciò che sperimentiamo oggi è più simile al contatto con un altro mondo che con la novità futura.
È a questo che si applica la riflessione di Constanza Michelson almeno a partire dai suoi due libri precedenti (Finché non varrà la pena vivere E fare la notte). Ha deciso di esplorare il nostro tempo senza cedere ai cliché delle cause nobili, non perché non esistano alcune cause giuste, ma perché il miglior impegno nei loro confronti è quello di chi ci impedisce di essere troppo sicuri di ciò che pensiamo e di ciò che dovremmo fare. Questa è, per definizione, una posizione antipolitica; cioè chiuso alla contingenza, ai bivi e alle opportunità.
II. NOSTALGIE
Sebbene si possa sempre soffrire per ciò che si perde, la particolare configurazione che questa assume nella nostalgia è un’esperienza veramente moderna; In effetti, il concetto fu coniato solo nel 1688 dal medico svizzero Johannes Hofer, e sebbene inizialmente designasse la malattia dei soldati che sentivano la mancanza della loro patria, il successivo sviluppo del concetto – fino a raggiungere vette morali e letterarie nel XIX secolo – si inserisce punto per punto con l’esperienza moderna per eccellenza: la rivoluzione come rottura tra passato e presente e lo sviluppo della dottrina del progresso.
In questo libro, l’autore ci segnala, molto vicino a Steiner e Dostoevskij, un’altra articolazione della nostalgia, che accompagna la fine stessa della modernità: la “nostalgia del disastro”, il fascino di una generazione per gli orrori vissuti dai suoi predecessori. Questo è tipico di un’era di vuoto e noia, in cui si suppone che le cose funzionino troppo, o sospettosamente, bene. Paradigma di ciò sarebbe quello Stato ancorato al mito ottocentesco della civiltà e del progresso europeo, che fu il terreno incolto in cui furono incubati i mostri feroci emersi durante la prima metà del XX secolo. Tra la nostalgia del disastro e la pulsione di morte esiste un rapporto stretto, in cui fa paura continuare a scrutare.
Questo era il milza, tipici del XIX secolo, che, come tante cose della fine di quell’epoca, prefiguravano quelli dell’inizio del XXI. Si tratta di qualcosa di simile, ma diverso: se la noia del XIX secolo raggiungeva maggiormente la borghesia; La noia odierna si estende attraverso la standardizzazione delle classi e delle eventuali differenze. E se quello di prima veniva dalla noia della civiltà e di tanta razionalità, quello di oggi viene dallo stato post-emancipatorio di tutto ciò.
A differenza di quella noia antica, la noia di oggi non ha più la fiducia nell’umanità per far funzionare qualcosa (per “autorizzarsi a guidare la storia”, scrive Michelson), perché oggi l’umanità è annoiata di se stessa. Non è strano che oggi non sia più tempo di progetti politici, ma di “esplosioni”, che potrebbero essere la migliore figura politica del mondo. presenzialismo per quanto riguarda le masse; cioè abdicazione o incapacità di produrre futuro. “Potere senza potere” qualcuno ha detto. A livello del soggetto individuale, è la figura dell’“operatore politico” a rubare il posto allo statista, quel personaggio da cui ci si aspettava coscienza storica: l’equilibrio di ciò che hai o non hai “per trasformare i sogni in progetti” (Berman). Il trader, invece, improvvisa e reagisce, bilancia piatti cinesi e specula, nel senso borsistico del termine.
III. PROVARE LA VITA
Riferirsi alla scrittura strutturante di questo libro come a una storia biografica può portare a un malinteso. Ebbene, è una storia non letterale, lineare o scontata: la “vita plausibile” non la troveremo qui, poiché è soprattutto la storia onesta di qualcuno che ipotizza che ora e i suoi attacchi al tema di ieri aver fatto. Quella ragazza che era, riferita alla terza persona, non è una mera scelta stilistica, ma la confessione di un sé come un altro. E, in realtà, a nessuno viene data altra alternativa. Ciò che accade è che funzioniamo meglio nella convinzione di essere uguali dall’inizio alla fine – come se avessimo la possibilità di essere coerenti – fino al punto di esaltarne la conseguenza come valore supremo. È il residuo di un antico concetto sferico di verità.
Da qui la domanda sotterranea che attraversa questo libro: cosa succede quando le cose dovrebbero fallire, ma alla fine non falliscono? Né la provvidenza né il caso operano, ma la libertà: “L’atto si padroneggia al bivio”, sostiene Michelson. Il significato viene costruito quando facciamo qualcosa con i nostri determinanti e li trasformiamo in motivi.
Libertà, è una parola troppo grande per i nostri tempi? La libertà non è più ciò di cui abbiamo bisogno per orientare il futuro dell’umanità, questo era il delirio umanista moderno. Ma l’umanesimo non deve essere un’illusione. Costretti alla moderazione, potremmo ormai parlare di un umanesimo “debole”, privo di un unico fondamento normativo ultimo e impedito dal dominio della ragione (Vattimo): la libertà umana non è altro che ciò che possiamo fare con la nostra vita, e, per estensione , con quello di chi ne fa parte, con un risultato mai scontato. L’unica cosa certa è che dovremo farci carico dei risultati. La responsabilità risulta essere la verifica della libertà.
E così come ha sottolineato Freud quando si fa riferimento al meccanismo di umanizzazione delle forze naturali incontrollabili: «Ci sentiremo più tranquilli in mezzo al turbamento e potremo elaborare psichicamente la nostra angoscia. Continuiamo forse impotenti, ma non ci sentiamo più paralizzati.
Questo testo è un estratto della presentazione del libro tenuta dall’autore a Valparaíso, il 7 giugno.