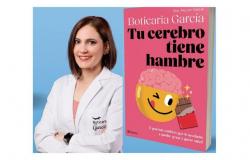Mercoledì scorso ho partecipato a un’attività organizzata dalla Fondazione FILBA, organizzatrice del Festival Internazionale della Letteratura di Buenos Aires. L’argomento sul quale doveva intervenire aveva un titolo pomposo: “I libri che mi salvarono la vita”. Mi è sembrato un po’ esagerato, perché esistono libri che ti salvano la vita? Ma riflettendoci un po’ di più, mi sono reso conto che i libri ti salvano sempre dal cadere nel baratro di qualunque cosa, molti ti portano in un luogo, per parafrasare Baudelaire, di “lusso, calma e voluttà” e altri semplicemente sono con te quando ne hai bisogno. Per i lettori incalliti, i libri ci accompagnano nei momenti difficili, alla visita dal medico, all’appuntamento di rottura, ad un viaggio da soli, per rendere più sopportabile ogni tipo di attesa. Come lettore, questo è quello che mi è successo in più di un’occasione. Come autore, questo è ciò che vorrei accadesse con ciò che scrivo: accompagnare qualcuno nel momento in cui ne ha bisogno.
Ci sono libri che forse non ti salvano, ma che fanno parte della tua vita. Con questa premessa ho cominciato a riempire uno zaino di libri per mostrarli ai presenti. Perché in quei casi i libri non sono solo il contenuto, ma anche le copie, le edizioni in cui leggiamo quelle storie, idee, poesie. Sono anche i nostri marchi, i commenti scritti a margine. Potremmo ricostruire la nostra vita con ciò che enfatizziamo in un determinato momento.
Ho colto l’occasione (un pubblico in cattività che si godeva un bicchiere di vino) per leggere estratti da quei libri. Leggere ad alta voce è una cosa che mi piace fin da bambino, quando a otto o nove anni, nei pomeriggi estivi a Lanús, ci sedevamo all’ombra con i miei amici per poter leggere loro. Le Follie di Isidoro O Le disavventure di Beanpole.
Ho detto che un libro che mi ha salvato la vita è stato Respirazione artificiale, di Ricardo Piglia. Quando lo lessi per la prima volta, quando avevo sedici anni, mi dissi che avrei voluto scrivere un giorno con le parole che usava Piglia. Era la prima volta che prendevo coscienza della lingua argentina, quella che dovevo usare se volevo fare lo scrittore. Un romanzo che ti insegna la tua lingua, che ti fa comprendere la tradizione letteraria, ma soprattutto che ti parla di un tempo (la dittatura) con parole eterne e leggibili sempre nel presente. Basta leggere il breve testo che appare sul retro di copertina dell’edizione Editorial Pomaire, forse il retro di copertina più corto della storia: “Tempi bui in cui gli uomini sembrano aver bisogno di aria artificiale per sopravvivere”. Proprio questo: lettere bianche su un immenso sfondo nero.
E cos’è la letteratura, cosa sono i libri se non una forma di respirazione artificiale nei tempi bui? Piglia dice in un altro punto del romanzo: “Bisogna saper guardare ciò che sta arrivando come se fosse già accaduto”. Buoni consigli per questa volta, ma c’è di più: “La storia argentina è l’allucinato, infinito monologo del sergente Cabral nel momento della sua morte, trascritto da Roberto Arlt”.
Mentre sceglievo i libri da portare all’incontro ho scoperto che la maggior parte erano poesie. Dei tanti volumi che avrei voluto condividere, infatti, ho preso solo una parte.
Ci sono poeti che mi hanno dato titoli ed epigrafi per i miei libri, come l’italiano Salvatore Quasimodo, autore della poesia “Ora vola il magro fiore”, che dice: “Non saprò mai nulla della mia vita,/ sangue oscuro e monotono. / Non saprò chi”.
Tra i poeti argentini, la cosiddetta Generazione dei 50 è stata per me – come Piglia – quella che ha segnato il percorso lungo il quale è passata la nostra lingua, oltre al fatto che questi autori hanno espresso le loro preoccupazioni politiche e sociali. Non furono i primi, ma lo fecero con un alto livello di lirismo. Sette di quei poeti, tra loro amici, realizzarono un’antologia con i loro testi e li inclusero senza chiarire chi avesse scritto ciascuna poesia, se non nell’indice finale. Il libro si chiama Antologia interna e riunisce bellissimi versi di Edgar Bayley, Miguel Brascó, César Fernández Moreno, Noé Jitrik, Ramiro de Casasbellas, Francisco Urondo e Alberto Vanasco. Un libro introvabile che comprai più di vent’anni fa in una libreria dell’usato. Penso ai diversi percorsi di vita di questi sette uomini, tutti così diversi. Hollywood avrebbe realizzato più di un film con le vite di questi scrittori.
A volte i libri che ci hanno salvato la vita ci riservano delle sorprese. Ad esempio, in uno di essi ho trovato una poesia ritagliata da un supplemento culturale. La poesia si intitola “A César Vallejo”, di Alberto Vanasco, poeta e romanziere eccezionale. L’ho ritagliato nel 1989 ed era dentro un libro, ma prima l’ho letto in pubblico quando dovevo farlo alla Prima Biennale d’Arte Giovane. Contesto: marzo 1989, l’agonia finale del radicalismo, dell’iperinflazione, dell’arroganza di un governo che non si rendeva conto che stava per cadere. Prima di leggere le mie poesie (che erano pessime), ho letto la poesia di Vanasco che dice: “La lingua non ci basta, compagno,/ per dire l’indicibile./(…) La lingua non ci serve, compagno,/ se Noi non spezziamo preventivamente le parole/ se non le masticiamo a priori con violenza/ e le maciniamo per un po’ ostinatamente./ (…) E tuttavia cantiamo/ cantiamo in tempo di delitto e di spoliazione/ ma noi non cantare questa volta ma l’altra / l’ora in cui tutti quelli che vorranno potranno cantare”.
Vanasco era amico di un altro poeta, Mario Trejo, uno dei più importanti della sua generazione. La poesia di Trejo è quasi tutta raccolta in un unico libro: L’uso della parola. Le sue poesie mi accompagnano sempre, come chi ha nel portafoglio la foto dei propri cari. C’è una poesia molto divertente (l’aggettivo è corretto) che si intitola “Appunti per una critica della ragione poetica”. In tre dei suoi versi provocatori scrive: «l’uomo nuovo deve guardarsi da due pericoli: / la destra quando è destrorso / la sinistra quando è sinistro».
Ha delle poesie d’amore incredibili (“Labbra libere”, “San Paolo visitato”), ma quella che mi rimane più impressa in questi giorni è quella che ha scritto dedicata a un suo amico che era stato imprigionato dalla dittatura di Francisco Franco. La poesia termina dicendo: “Il mio dolore e la mia gioia non sono serviti a nulla/ I miei errori non sono serviti a niente/ La notte può durare e durerà ancora/ L’alba è il compito dei sopravvissuti”.
Sono lì, nella tua biblioteca o in quella pubblica, in una libreria o su un sito di scambio gratuito. In formato cartaceo o digitale. Ci sono i libri che ci aspettano per continuare a salvarci la vita. Che romanzo, che volume di racconti o di saggi, che poesia ci accompagnerà in questi tempi bui. Spero che ci aiutino a vedere l’alba che meritiamo.